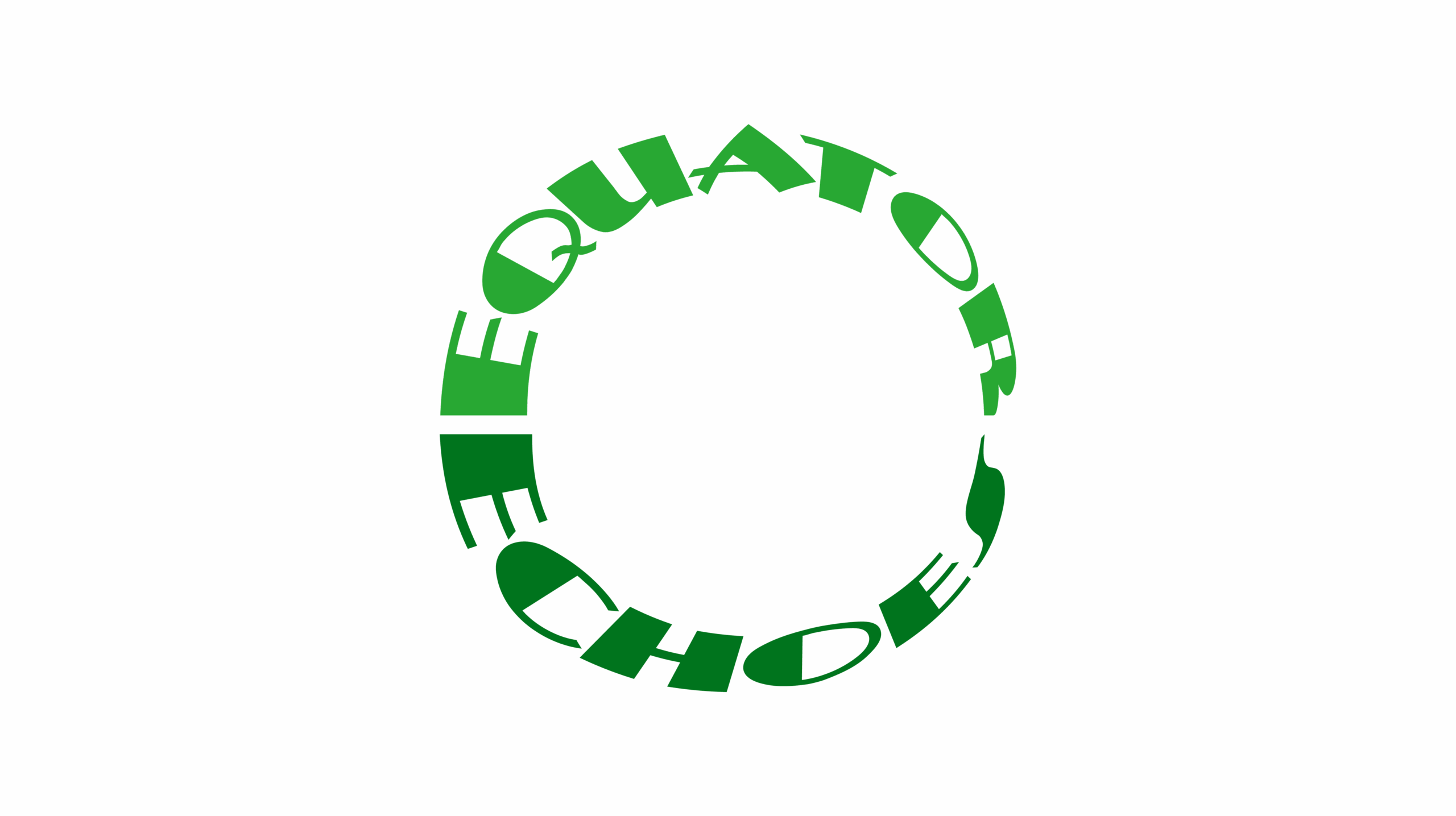Di Alessia D’Introno
La mancata condanna dei carnefici per i reati commessi nelle colonie e il fatto che i governi che seguirono dopo la caduta del regime non abbiano mai ufficializzato le loro colpe, ha incrementato la crescita di un immaginario collettivo dove ancora oggi il colonialismo è associato a una storia di poco conto e gli italiani un popolo di brava gente, mite e innocente1.
Se la rimozione storica ha alimentato l’illusione di un colonialismo italiano “mite e innocente,” il lavoro dell’artista Jermay Michael Gabriel la smantella pezzo per pezzo, rivelando le complessità e le contraddizioni di una storia che continua a plasmare il presente. In Cose Bizzarre, la sua personale italiana curata da Elisa Giuliano e ospitata da Artnoble, indaga come la memoria non sia mai neutrale, ma invece lasci nel tempo delle tracce difficili da rimuovere, anche se non impossibili.

Discutendo di queste tracce quasi indelebili, Jermay mette a nudo i meccanismi che hanno permesso a quella storia di essere distorta, semplificata o addirittura dimenticata. Nelle sue opere, come nelle lastre incise con i nomi di vie legate a episodi coloniali (Via Adwa, Via Dogali, Via Ambara), fa un viaggio simbolico in autobus che percorre tutta l’Italia. I nomi di queste vie riportano tre battaglie complesse. L’artista mostra come il linguaggio stesso si pieghi alle narrazioni coloniali, banalizzando tragedie e trasformando la violenza in folklore. Via Dogali segna la prima sconfitta italiana seguita da quella di Adwa, con la w corretta anziché con la u della versione coloniale, due sconfitte passate come vittorie.

La terza lastra fa riferimento ad Ambara, – come l’artista stesso spiega in una intervista – che gioca sulla somiglianza con il termine ambaradan, entrato nel lessico italiano come sinonimo di caos. La Battaglia di Amba Aradam faceva parte della brutale campagna italiana durante la seconda invasione dell’Etiopia nel 1936. Incapaci di rivendicare una vittoria chiara, le forze italiane bombardarono una grotta dove donne, bambini e parenti dei partigiani etiopi si erano rifugiati, uccidendo quasi 40.000 persone in quattro giorni. L’allora re dell’Africa Orientale Italiana proclamò: ‘Abbiamo fatto proprio un ambaradan. L’Etiopia è nostra!’2

Il suo lavoro destabilizza queste sedimentazioni, esponendo come la storia sia stata contaminata da miti nazionali e da un desiderio di auto-assoluzione. Attraverso materiali deteriorati, fotografie alterate dal tempo e installazioni che evocano la distruzione e la rinascita, l’artista ci costringe a confrontarci con dei momenti passati che non abbiamo conosciuto o che abbiamo dimenticato. L’errore più comune è quello di pensare di non aver incontrato e neppure di aver favorito quel pezzo di storia, così da lavarsene le mani. Queste memorie, al contrario, hanno continuato a perpetuare il presente. L’artista non si accontenta di portare alla luce ciò che è stato rimosso, il valore delle sue opere è nella sfida verso il pubblico a interrogarsi sul proprio ruolo nella eternizzazione di quelle narrazioni. Come la memoria architettonica, fotografica, storica e intellettuale continua a plasmare il ricordo e l’immaginario?


La memoria non può essere presa per ciò che è; deve essere riletta, riattivata, reinterpretata. Questo principio guida la pratica di Gabriel che non si stabilisce come detentore di una verità, ma solo come autista nel percorso che è la reminiscenza. I popoli descritti nei documentari dell’Istituto Luce come “bizzarri”, con le loro danze, i loro abiti e rituali3, da cui il nome della mostra, sono il punto di partenza per un ribaltamento dello sguardo coloniale. Ribaltando, visionando e capovolgendo le finte arbitrarietà coloniali si potranno, un giorno, riscrivere le rappresentazioni.
Jermay Michael Gabriel, Cose Bizzarre
Curata da Elisa Giuliano
7/11/2024 – 31/01/2025
Artnoble Gallery, Via Ponte di Legno 9 (MI)
Jermay Michael Gabriel è un artista transdisciplinare italo-etio-eritreo. Il suo lavoro si basa su uno sforzo sperimentale, e spesso estremo, di resistenza alla permanenza e all’inafferrabilità dell’archivio coloniale italiano, attraverso la sovversione dei suoi simboli di potere. La sua pratica artistica abbraccia sia il suono che l’arte contemporanea. Parte dal presupposto che gli spazi all’intersezione di molteplici forme di emarginazione, visibilità o rappresentazione non producono liberazione. Il trauma coloniale non ha una traiettoria lineare, così come la memoria. Affonda nelle fibre senza uno schema temporale e attraversa le generazioni, andando avanti e indietro tra passato, presente e futuro. Il processo di Gabriel racconta le dimensioni sfaccettate di questi viaggi, esorcizzando il trauma attraverso il suono, l’installazione e la performance, abbracciando le eredità culturali e le memorie collettive come forma di guarigione. Jermay Michael Gabriel è anche membro del duo musicale Plethor X insieme al sound designer Giovanni Isgrò. Inoltre, è fondatore e direttore di BHMM (Black History Month Milano) e fondatore di Kirykou (Milano). Tra le ultime mostre The Recovery plan: alle porte coi sassi, Toronto, 2024; Meskel, Toronto, 2024; Biennale Malta, 2024; Members Don’t Get Weary, Lagos Biennal, 2024; Stratificazioni, Artnoble, Milano, 2023; Museo delle Opacità, Museo delle Civiltà, Roma, 2023.
- Fiorella, Francesca Maria (2024), Il gioco della percezione nella rappresentazione dell’alterità. Il colonialismo italiano e le pratiche artistiche postcoloniali: due casi a confronto, «Scritture Migranti», a cura di Silvia Baroni e Guido Mattia Gallerani, n. 17/2023 ↩︎
- Nero, A phantasmagoric Journey. Through “Cose Bizzarre”: a conversation with Jermay Michael Gabriel ↩︎
- Elisa Giuliano, Testo critico ↩︎